The Witcher, la serie basata sui celebri romanzi di Andrzej Sapkowski e approdata su Netflix lo scorso 20 dicembre, ha rappresentato uno snodo importante e molto atteso per i molti fan del fantasy, tanto che in molti hanno apparentato il prodotto a Il Trono di Spade, serial della HBO fresco di chiusura e in grado di chiamare a raccolta un fandom particolarmente attivo e appassionato, quando non bellicoso e intransigente.
La fedeltà rispetto ai libri dell’autore polacco è relativa, con le esigenze della narrazione sul piccolo schermo e i dettami della serialità contemporanea a fare da ago della bilancia decisivo. Una scelta che giocoforza scontenterà i puristi, ma che allo stesso tempo, grazie all’apporto dell’ideatrice dello show Lauren Schmidt Hissrich, ha garantito una maggiore intelligibilità e spettacolarità ai non pochi sviluppi di un racconto sfaccettato e ingombrante.
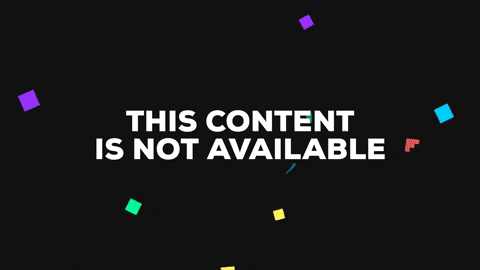
The Witcher, infatti, non ha al suo interno nulla che non sia ascrivibile a un’idea monumentale di racconto audiovisivo, anche se la sensazione è che il tutto sia inferiore alla somma delle sue parti e che la serie abbia un impianto a tratti eccessivamente goffo e pachidermico, che ne pregiudica l’appeal e la fluidità, annacquandone tanto il fascino quanto le non poche suggestioni.
Tali limiti non compromettono però del tutto le componenti più seducenti, a cominciare da un’idea insistita di caducità, con la metafora reiterata del “fiore chiamato a morire” e una sessualità che, seppur usata con la stessa disinvoltura di Game of Thrones, tradisce una matrice meno politica, più prossima a uno strambo e imprevedibile incrocio di leggerezza e disperazione.
A emergere nelle varie peregrinazioni all’interno del Continente, fin dalle premesse, è però soprattuto il Geralt di Rivia di Henry Cavill, figura statuaria e geneticamente modificata che utilizza i cosiddetti Segni per attingere alla magia e volgerla a proprio favore. La sua scorza ipertrofica di solitudine e abbandono, granitica e all’apparenza impossibile da scalfire, incarna alla perfezione lo spirito ombroso e predatorio di The Witcher, con fendenti di violenza sempre sul punto di venire sguainati e un approccio selvaggio al fantastico.

Più che sanguinario, tuttavia, The Witcher corre il rischio di risultare il più delle volte esangue. Non certo per il suo protagonista, mercenario alle calcagna dei mostri, che aveva tutte le carte in regola per essere una presenza d’impatto, quanto per la debolezza impalpabile di ciò che malmostosamente lo circonda e delle sue interazioni, a partire da quelle con la principessa Ciri di Freya Allan e la Yennefer di Anya Chalotra, personaggi stimolanti nelle premesse ma alla prova dei fatti decisamente sacrificati dalla bulimia di atmosfere, ambienti, rivoli di senso e di racconto non certo irresistibili.
Il femminismo che la serie propone, presa di coscienza a partire dalla consapevolezza e dal rischio da parte delle donne di essere bollate come contenitori vuoti, da cui l’uomo può attingere prendendone tanto la vacuità (in senso etimologico) quanto la solitudine, è però un altro specchietto per le allodole, più abbozzato che sviluppato. Ma anche la conferma ulteriore di quanto The Witcher mostri la propria prestanza quasi solo mostrando i muscoli - non soltanto quelli di Cavill - sul piano visivo e, azzardando, anche su quello organolettico, in compenso decisamente all’altezza del dispendio produttivo e della cura dei dettagli intavolata.
Un esborso che ha portato Netflix a pianificarne la seconda stagione senza valutarne la risposta del pubblico, con la coscienza evidente che il prontuario minimo dell’hype, in dotazione già prima della diffusione in streaming, potesse bastare a se stesso.
Davide Stanzione