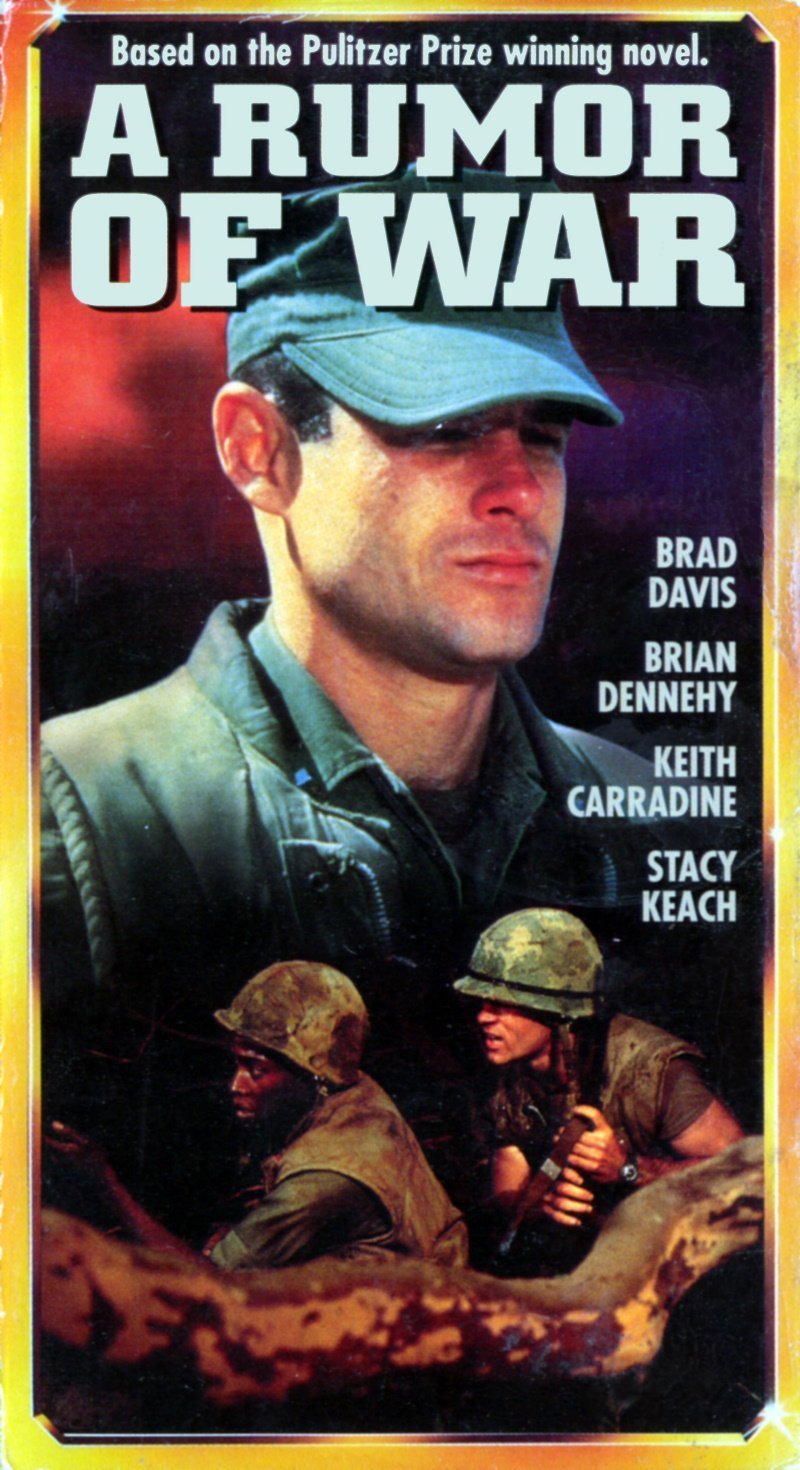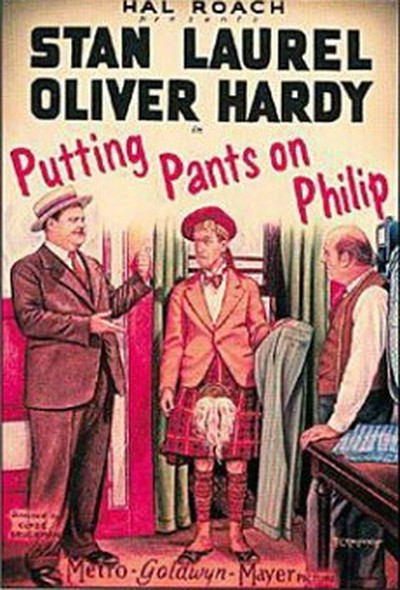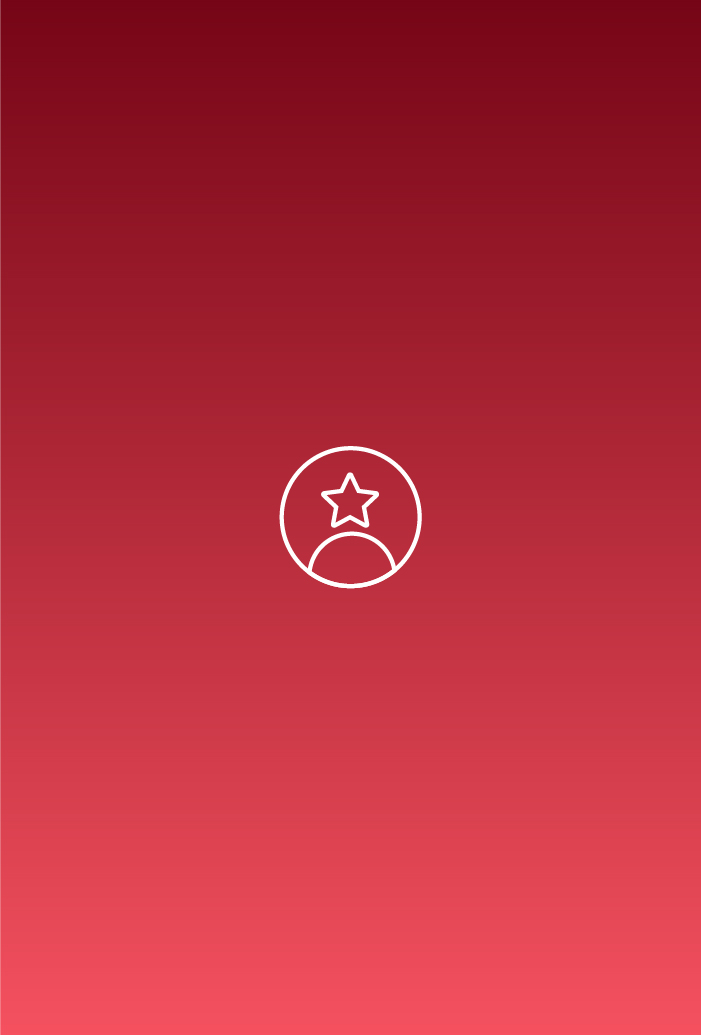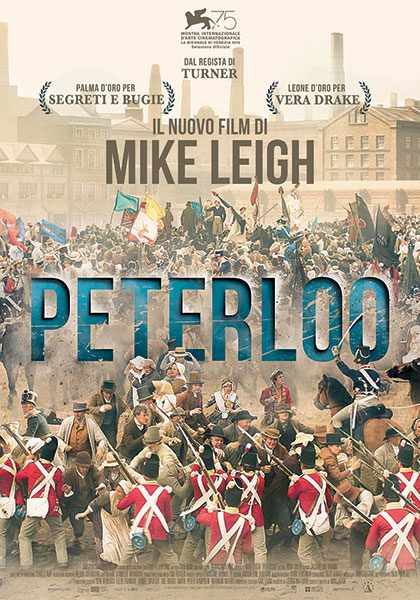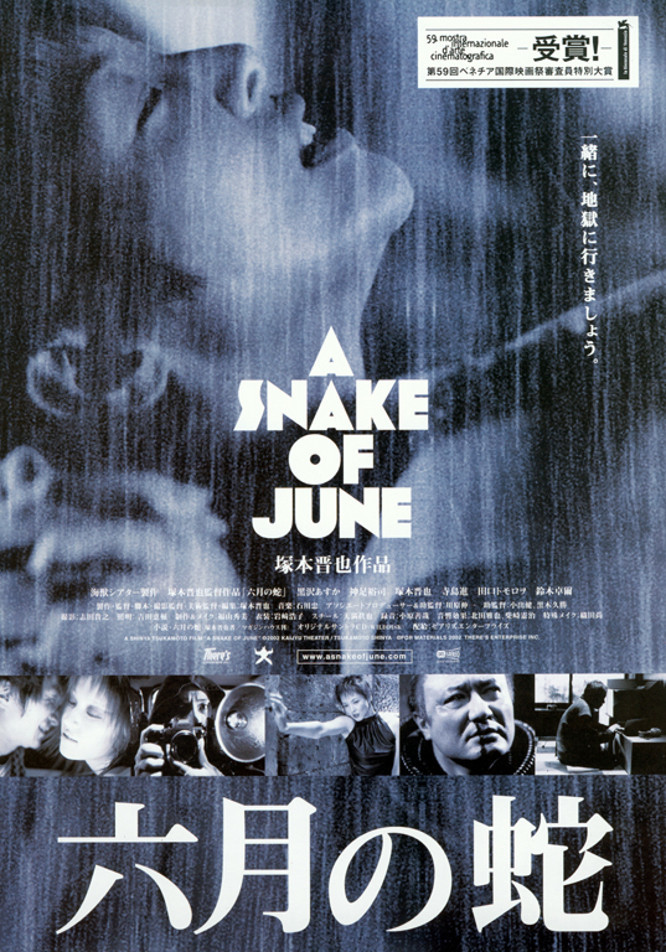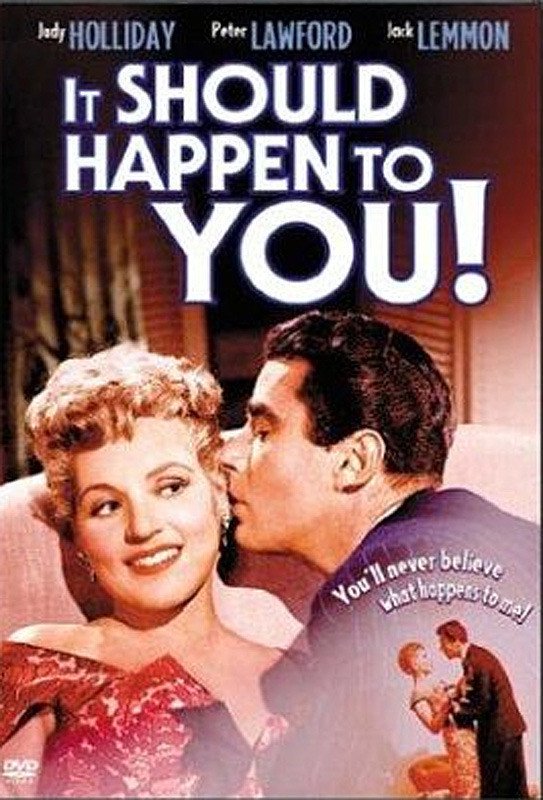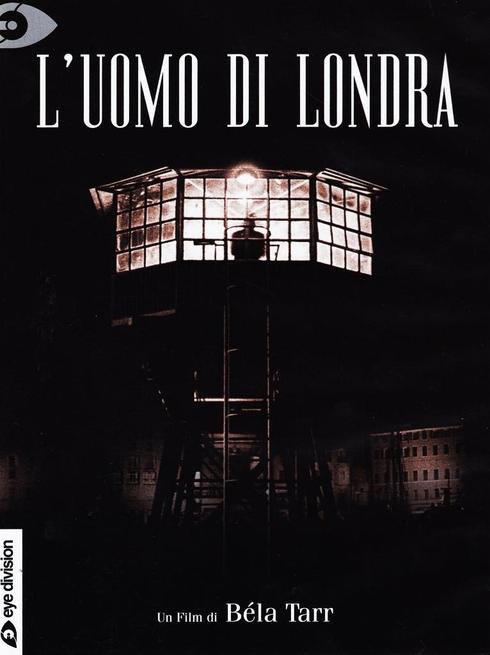Seopyeonje
Seopyeonje
Durata
112
Formato
Regista
Yubong (Kim Myung-gon) è un cantante girovago che decide di insegnare la sua arte ai due figli adottivi. La sua abnegazione porterà a esiti drammatici e alla separazione della famiglia.
Con questo film (il suo novantatreesimo) Im Kwon-taek rompe tutti i record del periodo, facendolo diventare il lungometraggio coreano più visto in patria fino a quel momento, nonostante una società che preferiva di gran lunga le produzioni hollywoodiane. Ed è proprio una pellicola sulla resistenza delle tradizioni, in un dopoguerra che avanza verso il globalismo e dove la musica occidentale sta prendendo sempre più piede, a sfavore del classico genere pansori, in cui una voce solista è accompagnata da un tamburo. La resistenza del protagonista, che è anche incapacità di adattamento, trascina lui e i suoi figli in una spirale autodistruttiva, e i pur nobili valori del canto sembrano via via essere sempre meno sufficienti a giustificare uno stile di vita di povertà e nomadismo. Il figlio si ribella e fugge mentre la figlia resta, e il film si sviluppa attraverso l’uso semplice ed efficace dei flashback del primo, che cerca di ritrovare la sorella perduta. Una regia precisa e controllata regala inquadrature affascinanti senza inutili fronzoli estetizzanti, e va di pari passo con la severità tecnica del canto: molte le scene a camera fissa durante le esecuzioni musicali e le lezioni teoriche, che non appesantiscono il film, ma anzi mettono in posizione centrale l’arte e il suo senso più intimo, decadente ed estremamente vitale a un tempo. Intense le prove attoriali e calibratissima la sceneggiatura, scritta dallo stesso protagonista Kim Myung-gon sulla base di un romanzo di Yi Cheong-jun. Il titolo fa riferimento alla scuola di pansori seguita dai personaggi principali.
Con questo film (il suo novantatreesimo) Im Kwon-taek rompe tutti i record del periodo, facendolo diventare il lungometraggio coreano più visto in patria fino a quel momento, nonostante una società che preferiva di gran lunga le produzioni hollywoodiane. Ed è proprio una pellicola sulla resistenza delle tradizioni, in un dopoguerra che avanza verso il globalismo e dove la musica occidentale sta prendendo sempre più piede, a sfavore del classico genere pansori, in cui una voce solista è accompagnata da un tamburo. La resistenza del protagonista, che è anche incapacità di adattamento, trascina lui e i suoi figli in una spirale autodistruttiva, e i pur nobili valori del canto sembrano via via essere sempre meno sufficienti a giustificare uno stile di vita di povertà e nomadismo. Il figlio si ribella e fugge mentre la figlia resta, e il film si sviluppa attraverso l’uso semplice ed efficace dei flashback del primo, che cerca di ritrovare la sorella perduta. Una regia precisa e controllata regala inquadrature affascinanti senza inutili fronzoli estetizzanti, e va di pari passo con la severità tecnica del canto: molte le scene a camera fissa durante le esecuzioni musicali e le lezioni teoriche, che non appesantiscono il film, ma anzi mettono in posizione centrale l’arte e il suo senso più intimo, decadente ed estremamente vitale a un tempo. Intense le prove attoriali e calibratissima la sceneggiatura, scritta dallo stesso protagonista Kim Myung-gon sulla base di un romanzo di Yi Cheong-jun. Il titolo fa riferimento alla scuola di pansori seguita dai personaggi principali.